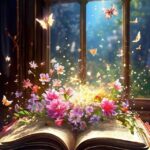Per quanto concerne l'oggetto dell' obbligazione sorta dall'omicidio volontario, bisogna analizzare la natura del credito dell'avente diritto, danneggiato dal reato. L'oggetto dell'obbligazione è il taglione. Tuttavia, i giuristi si sono chiesti se il creditore, anziché ottenere l'applicazione del taglione, possa chiedere una compensazione pecuniaria senza il consenso del debitore oppure, se debba concedere il perdono in modo gratuito, qualora questi rifiuti di pagare la diya. La scuola dei malikiti e shafi'iti ritiene invece che l'avente diritto, abbia la possibilità di scegliere tra taglione e diya, senza l'intervento del debitore. Una parte della dottrina dei malikiti e shafi'ti, ritiene che qualora il creditore perdoni e disponga solo la diya, il debitore è tenuto ad adempiere senza lesinare. Tuttavia, un'altra parte della dottrina, ritiene che qualora l'assassino accetti di versare la diya, il creditore dovrà accettarla e perseguirlo "con benevolenza". Nell'ipotesi inerente la prima interpretazione, non si deve aspettare la maggiore età per applicare il taglione, qualora l'assassino non voglia versare la diya. Nel secondo caso, è necessario invece che il creditore sia maggiorenne. La diya, viene definita legale e di valore prestabilito ed obbligatoria nelle ipotesi di omicidio non intenzionale. Il valore della diya è fisso e varia a seconda che si tratti di delitti colposi o quasi-intenzionali. Il prezzo del sangue aumenta nel caso di un padre che volutamente uccide un figlio oppure qualora la condotta criminosa, venga posta in essere nei mesi sacri, all'interno della Mecca o in danno di un familiare donna. La diya è detta negoziale, qualora sancita sulla scia di un accordo, nei reati intenzionali di sangue. Per quanto concerne il diritto di pretendere il taglione o concedere il perdono, i malikiti ritengono spetti agli agnati mentre altra parte della dottrina, agli eredi. Tuttavia, mentre per i malikiti, le donne non hanno la possibilità di esprimere la propria volontà, per gli hanafiti invece, anche le donne possono concedere il perdono. Il diritto al taglione spetta alla vittima e si trasmette ai suoi eredi in base alla sua volontà. Per quanto concerne gli effetti del perdono, i malikiti, a differenza degli shafi'iti e hanafiti, ritengono possano applicarsi ulteriori sanzioni come 100 frustate ed un anno di reclusione. Tuttavia, l'imam, valuta la necessità di applicare misure di sicurezza al soggetto ritenuto pericoloso. Nel caso di perdono a titolo oneroso, la diya diviene esigibile e viene acquisita dal patrimonio dell'assassino. In merito all'esecuzione del taglione, le scuole di pensiero concordano nell'applicazione della morte, con lo stesso metodo attuato nei riguardi della vittima o in alternativa decapitando il reo con la spada. Per quanto concerne la c.d. kaffara, ossia l'espiazione religiosa, gli shafi'iti ritengono sia prevista sempre e a prescindere dalla volontà dell' azione criminosa, mentre Malikiti e hanafiti, ritengono applicabile la Kaffara solo per l' omicidio colposo. Premesso che i trattati internazionali sui diritti umani VIETANO l'applicazione della pena di morte nei confronti di persone minori di 18 anni all'atto della commissione del reato, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione sui diritti dell'infanzia proibiscono l'applicazione della pena di morte. Nel 2007, l'ONU, ha approvato la risoluzione per la moratoria universale della pena di morte, volta a sospendere l'applicazione della pena di morte in tutti i paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Costituzione italiana, all'art. 27, sancisce un principio di civiltà prima ancora che di legalità, proibendo la pena di morte ed improntando la pena sul principio di rieducazione, di non colpevolezza fino a condanna definitiva e di personalità della responsabilità penale, stabilendo che: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità". L'articolo 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, l. n. 354/1975, dispone che: "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi". “È una bella prigione, il mondo”, asseriva WILLIAM SHAKESPEARE. Una prigione mentale da cui non ne usciremo vivi se non liberandoci dalle catene mentali, attraverso l'applicazione dei diritti umani inalienabili erga omnes, il principio di pari opportunità, pari dignità ed il diritto all'autodeterminazione e alla felicità per ogni cittadino del mondo.
L’oggetto dell’ obbligazione nell’ Islam